Inceneritore: ecco le verità nascoste
Scritto da Coordinamento No Inceneritore Rifiutizero Torino
Pubblicato Mercoledì 11 Gennaio 2012, ore 7,00
Pubblicato Mercoledì 11 Gennaio 2012, ore 7,00
Replica all'intervento di Trm. La contrapposizione con la raccolta differenziata è un dato di fatto. E recenti studi hanno messo in luce i pericoli peer la salute pubblica
 Rispondiamo, con il presente intervento, alla lettera «Facciamo chiarezza sul termovalorizzatore», pubblicata sul Ballatoio il 22 dicembre 2011 e firmato da Elisa Nardi, dell’Ufficio Comunicazione TRM S.p.A. La nostra risposta intende affrontare “punto per punto” le questioni sollevate nel suddetto articolo, mostrando e argomentando l’inesattezza di molte affermazioni.
Rispondiamo, con il presente intervento, alla lettera «Facciamo chiarezza sul termovalorizzatore», pubblicata sul Ballatoio il 22 dicembre 2011 e firmato da Elisa Nardi, dell’Ufficio Comunicazione TRM S.p.A. La nostra risposta intende affrontare “punto per punto” le questioni sollevate nel suddetto articolo, mostrando e argomentando l’inesattezza di molte affermazioni.
1. Rapporto termovalorizzatori/raccolta differenziata. TRM sostiene che la "termovalorizzazione" dei rifiuti - in realtà combustione di materiali eterogenei, con scarso rendimento energetico - “non è in alcun modo contrapposta” alla raccolta differenziata. A dimostrazione di questo, viene suggerita una relazione tra concentrazione di inceneritori ed elevata percentuale di RD (raccolta differenziata) nel Nord Italia: in parole povere, si sostiene che anche laddove gli inceneritori sono presenti in numero maggiore - le regioni settentrionali della Penisola, appunto - la RD anziché diminuire risulta in costante aumento. Tale relazione in realtà non esiste: se la percentuale di RD al Nord è più alta il motivo è che vi sono molti Comuni virtuosi presenti in province prive di inceneritori - come ad esempio Novara e Belluno - che con le loro RD al 70, 80 e talvolta quasi 90% (Ponte delle Alpi in provincia di Belluno è il primatista con una 86,4% di RD) contribuiscono ad aumentare la media. Inoltre c’è da considerare che nel sud Italia i costi di smaltimento in discarica sono notevolmente inferiori a quelli praticati nel nord e sono anche inferiori ai costi di gestione della raccolta differenziata. Questo è causato molte volte dalla non ottemperanza alle leggi vigenti attraverso infiltrazioni della criminalità organizzata (vd. il clan dei Casalesi).
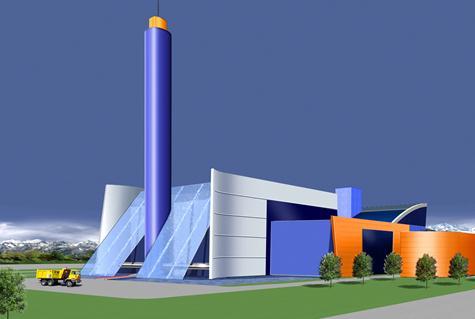 Al contrario, la contrapposizione tra RD e inceneritori è un dato di fatto. Prendiamo come esempio Milano e Brescia, province lombarde dove sono attivi grandi inceneritori. Tali province si collocano agli ultimi posti in Lombardia quanto a percentuale di raccolta differenziata: 47% per quella di Milano (con il capoluogo fermo al 33,8%) e 44,3% per quella di Brescia (con la città ferma al 39.1%). Questi dati sono tratti dal dossier Comuni Ricicloni di Legambiente Lombardia, presentato lo scorso 14 dicembre. Ulteriore spunto di riflessione è l'ambiguità della frase di TRM "il termovalorizzatore di Torino Gerbido è stato dimensionato prevedendo che nel territorio della Provincia di Torino si raggiunga almeno una media del 50% di raccolta differenziata”. È dal 2006, infatti, che l'Italia - recependo le direttive comunitarie - ha stabilito per legge (art. 205 del Dlgs 152/2006) che entro il 31.12.2012 la raccolta differenziata debba raggiungere il 65% in tutti gli ambiti territoriali. Aver progettato e avviato la costruzione dell'inceneritore del Gerbido prevedendo che quando l'impianto entrerà in funzione nel 2014 la RD in provincia di Torino toccherà il 50% rivela due aspetti preoccupanti: da un lato la consapevolezza - o forse la volontà - che Torino e provincia non raggiungano l'obiettivo del 65% entro il 2012, dall'altro - se anche tale obiettivo sarà centrato - il sospetto che per alimentare l'inceneritore e salvaguardarne la "produttività" si "importino" rifiuti da fuori provincia. Del resto, se l'inceneritore non brucerà 421.000 tonnellate di rifiuti all'anno per 20 anni non genererà profitti: un rischio che le amministrazioni comunali interessate, nonché i soggetti privati e le banche che hanno investito non possono permettersi.
Al contrario, la contrapposizione tra RD e inceneritori è un dato di fatto. Prendiamo come esempio Milano e Brescia, province lombarde dove sono attivi grandi inceneritori. Tali province si collocano agli ultimi posti in Lombardia quanto a percentuale di raccolta differenziata: 47% per quella di Milano (con il capoluogo fermo al 33,8%) e 44,3% per quella di Brescia (con la città ferma al 39.1%). Questi dati sono tratti dal dossier Comuni Ricicloni di Legambiente Lombardia, presentato lo scorso 14 dicembre. Ulteriore spunto di riflessione è l'ambiguità della frase di TRM "il termovalorizzatore di Torino Gerbido è stato dimensionato prevedendo che nel territorio della Provincia di Torino si raggiunga almeno una media del 50% di raccolta differenziata”. È dal 2006, infatti, che l'Italia - recependo le direttive comunitarie - ha stabilito per legge (art. 205 del Dlgs 152/2006) che entro il 31.12.2012 la raccolta differenziata debba raggiungere il 65% in tutti gli ambiti territoriali. Aver progettato e avviato la costruzione dell'inceneritore del Gerbido prevedendo che quando l'impianto entrerà in funzione nel 2014 la RD in provincia di Torino toccherà il 50% rivela due aspetti preoccupanti: da un lato la consapevolezza - o forse la volontà - che Torino e provincia non raggiungano l'obiettivo del 65% entro il 2012, dall'altro - se anche tale obiettivo sarà centrato - il sospetto che per alimentare l'inceneritore e salvaguardarne la "produttività" si "importino" rifiuti da fuori provincia. Del resto, se l'inceneritore non brucerà 421.000 tonnellate di rifiuti all'anno per 20 anni non genererà profitti: un rischio che le amministrazioni comunali interessate, nonché i soggetti privati e le banche che hanno investito non possono permettersi. 2. Emissioni di nanopolveri. Ammesso che l'impianto rispetti i livelli di emissione stabiliti per legge, sappiamo che essi non sono purtroppo commisurati alla reale nocività per gli esseri viventi: ciò è tragicamente vero in particolare per quanto riguarda le diossine e i furani, delle quali gli inceneritori sono una tra le fonti primarie (generandone in Italia il 13%). Le diossine sono state classificate dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) come cancerogeni certi per l’uomo (Cat.1): questo significa che anche assunzioni di infinitesime quantità possono portare all’insorgere di tumori, disturbi ai sistemi immunitario, ormonale, riproduttivo. Ricordiamo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito in 2pg/Kg, picogrammi (un milionesimo di milionesimo di grammo, o 0,000000000001 g) per chilogrammo di peso corporeo, il limite oltre il quale la diossina inizia ad essere dannosa per l’organismo umano: tale limite, stabilito dall’Unione Europea, è tra l’altro mille volte superiore a quello fissato dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente statunitense. Per avere un metro di paragone, facciamo rilevare che l’impianto del Gerbido sarà autorizzato ad emettere giornalmente una quantità di diossina pari a 972 milioni di picogrammi. Queste sostanze, che ricadono sui campi coltivati anche a molti chilometri di distanza dagli impianti d'incenerimento, vengono assunte dall'uomo prevalentemente attraverso il cibo e si accumulano nei tessuti adiposi. Tra le categorie più a rischio ci sono sicuramente i neonati e i bambini, dal momento che il loro alimento principale, il latte materno, è uno dei maggiori "contenitori" di diossina.
2. Emissioni di nanopolveri. Ammesso che l'impianto rispetti i livelli di emissione stabiliti per legge, sappiamo che essi non sono purtroppo commisurati alla reale nocività per gli esseri viventi: ciò è tragicamente vero in particolare per quanto riguarda le diossine e i furani, delle quali gli inceneritori sono una tra le fonti primarie (generandone in Italia il 13%). Le diossine sono state classificate dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) come cancerogeni certi per l’uomo (Cat.1): questo significa che anche assunzioni di infinitesime quantità possono portare all’insorgere di tumori, disturbi ai sistemi immunitario, ormonale, riproduttivo. Ricordiamo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito in 2pg/Kg, picogrammi (un milionesimo di milionesimo di grammo, o 0,000000000001 g) per chilogrammo di peso corporeo, il limite oltre il quale la diossina inizia ad essere dannosa per l’organismo umano: tale limite, stabilito dall’Unione Europea, è tra l’altro mille volte superiore a quello fissato dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente statunitense. Per avere un metro di paragone, facciamo rilevare che l’impianto del Gerbido sarà autorizzato ad emettere giornalmente una quantità di diossina pari a 972 milioni di picogrammi. Queste sostanze, che ricadono sui campi coltivati anche a molti chilometri di distanza dagli impianti d'incenerimento, vengono assunte dall'uomo prevalentemente attraverso il cibo e si accumulano nei tessuti adiposi. Tra le categorie più a rischio ci sono sicuramente i neonati e i bambini, dal momento che il loro alimento principale, il latte materno, è uno dei maggiori "contenitori" di diossina.
A titolo di esempio ricordiamo che, nel 2008, la Centrale del Latte di Brescia (città dove è presente l’inceneritore più grande d’Italia) ha riscontrato la presenza di diossine - con una tossicità equivalente ben oltre i limiti di soglia (tra i 6,5 e gli 8 picogrammi per grammo di grasso) - nel latte proveniente da sette aziende agricole ubicate nei pressi dell’impianto d’incenerimento. Altre analisi effettuate su alcune mamme di Brescia hanno evidenziato una tasso di diossina pari a 147 pg/g di grasso nel latte materno. Nel 2007, sempre a Brescia, l’Istituto Superiore di Sanità ha misurato le diossine del tipo PCDD-F presenti nell’aria. L’indagine è stata condotta nel mese di agosto, quando il traffico risulta ridotto e quando le principali industrie sono chiuse. Periodo in cui, tuttavia, l’inceneritore funziona regolarmente. Il confronto con altre misurazioni, condotte negli ultimi anni in diverse località nella stagione estiva, mostra chiaramente come le concentrazioni di diossine nell’aria di Brescia siano le maggiori, con quantitativi almeno tripli rispetto alla media. Numerosi altri studi epidemiologici dimostrano, inoltre, gli effetti reali degli impianti d'incenerimento sulle popolazioni che risiedono nei dintorni: basta citare lo studio effettuato - sempre nel 2007 - in provincia di Venezia dal Registro Tumori dell’Istituto Oncologico Veneto.
 È la più convincente dimostrazione esistente in letteratura di un aumento di rischio di cancro associato alla residenza vicino a inceneritori: esso evidenzia come il rischio aumenti di 3,3 volte fra i soggetti esposti al più alto livello e per periodi di tempo più lunghi. Si possono poi citare le ricerche Renzi et al. 2006, fatta a Forlì, che ha riscontrato un incremento della mortalità femminile per tumori alla mammella e al colon (tra il +17% e il +54%), oppure Biggeri et al. (Trieste 1996) e Chellini et al. (Prato 2002), nei quali vengono evidenziati aumenti di rischio per il cancro polmonare. Anche all’estero non mancano esempi di indagine accurata. Nel 2008 uno studio francese condotto dall’Institut de Veille Sanitaire ha rilevato un aumento - in tutte le aree dove sono presenti impianti d’incenerimento - non solo di tumori nella popolazione femminile, ma anche di linfomi maligni, di tumori del fegato e di sarcomi dei tessuti molli per entrambi i sessi. Da ricordare inoltre il 4° Rapporto della Società Britannica di Medicina Ecologica, anch’esso del 2008, che nelle molte e documentate considerazioni ricorda come nei pressi degli inceneritori si riscontrino tassi più elevati di difetti alla nascita e di tumori negli adulti e nei bambini. Tornando in Italia, ultimo in ordine di tempo, ma non meno importante e significativo, è lo studio Moniter della Regione Emilia Romagna per indagare gli effetti sull’ambiente e sulla salute nelle popolazioni residenti in prossimità degli 8 inceneritori presenti sul territorio regionale: i risultati hanno evidenziato un incremento dei tumori al pancreas, al fegato, al polmone (nella popolazione di sesso maschile), al colon, alle ovaie e all’endometrio (nel sesso femminile) e infine dei linfomi di Hodgkin in entrambi i sessi. In aggiunta sono stati evidenziati: aumento dei rischi per i neonati di peso inferiore alla nascita, incremento di "nascite pre-termine”, andamento crescente di aborti spontanei in relazione ai livelli di esposizione e andamento crescente delle malformazioni (sempre in base ai livelli espositivi). Per quanto riguarda le polveri ultrafini emesse (di diametro inferiore alle PM 2,5) non esistono ad oggi filtri in grado di bloccarle né apparecchiature in grado di valutarle.
È la più convincente dimostrazione esistente in letteratura di un aumento di rischio di cancro associato alla residenza vicino a inceneritori: esso evidenzia come il rischio aumenti di 3,3 volte fra i soggetti esposti al più alto livello e per periodi di tempo più lunghi. Si possono poi citare le ricerche Renzi et al. 2006, fatta a Forlì, che ha riscontrato un incremento della mortalità femminile per tumori alla mammella e al colon (tra il +17% e il +54%), oppure Biggeri et al. (Trieste 1996) e Chellini et al. (Prato 2002), nei quali vengono evidenziati aumenti di rischio per il cancro polmonare. Anche all’estero non mancano esempi di indagine accurata. Nel 2008 uno studio francese condotto dall’Institut de Veille Sanitaire ha rilevato un aumento - in tutte le aree dove sono presenti impianti d’incenerimento - non solo di tumori nella popolazione femminile, ma anche di linfomi maligni, di tumori del fegato e di sarcomi dei tessuti molli per entrambi i sessi. Da ricordare inoltre il 4° Rapporto della Società Britannica di Medicina Ecologica, anch’esso del 2008, che nelle molte e documentate considerazioni ricorda come nei pressi degli inceneritori si riscontrino tassi più elevati di difetti alla nascita e di tumori negli adulti e nei bambini. Tornando in Italia, ultimo in ordine di tempo, ma non meno importante e significativo, è lo studio Moniter della Regione Emilia Romagna per indagare gli effetti sull’ambiente e sulla salute nelle popolazioni residenti in prossimità degli 8 inceneritori presenti sul territorio regionale: i risultati hanno evidenziato un incremento dei tumori al pancreas, al fegato, al polmone (nella popolazione di sesso maschile), al colon, alle ovaie e all’endometrio (nel sesso femminile) e infine dei linfomi di Hodgkin in entrambi i sessi. In aggiunta sono stati evidenziati: aumento dei rischi per i neonati di peso inferiore alla nascita, incremento di "nascite pre-termine”, andamento crescente di aborti spontanei in relazione ai livelli di esposizione e andamento crescente delle malformazioni (sempre in base ai livelli espositivi). Per quanto riguarda le polveri ultrafini emesse (di diametro inferiore alle PM 2,5) non esistono ad oggi filtri in grado di bloccarle né apparecchiature in grado di valutarle.
Inoltre il paragone con caldaie e automezzi non regge, poiché in un inceneritore non si brucia un combustibile noto e omogeneo come benzina o metano, ma un assortimento molto vario e spesso imprevedibile di materiali. Portiamo inoltre l’attenzione sui seguenti confronti: 1) Per teleriscaldare 17 mila abitazioni (fonte TRM) l’impianto è autorizzato a emettere una quantità di polveri paragonabile a quella emessa da 120 mila caldaie domestiche a gasolio o 456 mila a metano. 2) Per quanto riguarda il traffico urbano possiamo dire che, calcolando una percorrenza media di 15 km al giorno nel contesto cittadino, l’inceneritore è autorizzato ad emettere una quantità di polveri paragonabile a quella sprigionata da 213 mila auto diesel di categoria Euro 4. Tutto questo in un contesto già provato come quello torinese, dove dal 2001 si supera ampiamente la soglia limite annuale di polveri sottili (40 microgrammi per metrocubo). Ricorrere ad un impianto di incenerimento, che contribuirà a far salire ulteriormente la concentrazione degli inquinanti in atmosfera, è in conflitto con il dovere di tutela della salute dei cittadini a cui ogni pubblica amministrazione dovrebbe ottemperare. Non si può non affrontare, poi, il problema delle ceneri prodotte dalla combustione (la cui quantità in peso è pari a circa il 30% dei rifiuti immessi in un inceneritore). La frazione “volatile” di esse è pericolosa e dovrebbe pertanto essere stoccata in discariche speciali, nel caso del Gerbido non ancora individuate. L’utilizzo della parte rimanente per i sottofondi stradali o come riempitivo nei mattoni per fabbricati appare problematico, perché tali ceneri devono prima essere rese “inerti”, ossia non più in grado di nuocere dato il loro elevato tasso di pericolosità.
3. Incentivi. Per quanto riguarda gli incentivi, anche se dal 1999 i contributi CIP6 sono stati sostituiti dai Certificati Verdi, essi in realtà non spetterebbero agli inceneritori: il problema è che l'Italia non si attiene alle direttive europee in materia. In tutta Europa la vendita di elettricità prodotta bruciando rifiuti avviene a prezzi molto simili a quella dell’elettricità prodotta da fonti convenzionali (olio combustibile, carbone, metano), pari a circa 4 centesimi per chilowattora. In Italia la vendita di elettricità prodotta con un inceneritore frutta al gestore dell’impianto da 9 a 14 centesimi a chilowattora. Questo significa che il gestore, per ogni tonnellata di rifiuto incenerito, grazie all’elettricità prodotta (0,5 chilowattora per chilogrammo di rifiuto incenerito), riceve un incentivo che varia da 25 a 50 euro (per l’impianto del Gerbido infatti sono previsti 18 milioni di euro annui dai Certificati Verdi). Questo flusso di denaro esce dai portafogli di tutte le famiglie italiane, con un prelievo “occulto” del 7% sulla bolletta della luce. L'inceneritore ha pertanto un evidente fine lucrativo, che però risulterebbe in realtà inesistente se non si reggesse su tale sistema di incentivi non dovuti. Verificando, infatti, lo schema di Conto Economico predisposto da TRM per l’anno 2013 ci accorgiamo che senza i Certificati Verdi l’impianto avrebbe un passivo annuo di almeno 7 milioni di euro.
 Il fine lucrativo è tuttavia solo per pochi: l'inceneritore distrugge infatti preziosi materiali riutilizzabili, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, dove occorre evitare il più possibile gli sprechi. Una valida alternativa - che costerebbe un quinto rispetto all’inceneritore del Gerbido, per il quale si spendono invece 503 milioni di euro - è il Trattamento a Freddo Meccanico Biologico (TMB), con cui viene prodotta anche energia, senza però danneggiare l’ambiente e la salute con l’emissione di fumi altamente inquinanti. Tale procedimento consente di ricuperare il 70% circa di rifiuti in ingresso indifferenziati e/o avanzati dalla raccolta differenziata sfruttando l’abbinamento di metodi meccanici e di processi biologici, come la digestione anaerobica e il compostaggio. All’interno di questi impianti l’impiego di tecnologie all’avanguardia (come l’utilizzo di sistemi magnetici per separare i materiali contenenti metalli) non esclude anche il ricorso a metodi più tradizionali, ma non per questo meno efficaci, come la differenziazione “a mano” dei rifiuti. Il TMB è pertanto vantaggioso non solo perché consente il riutilizzo della porzione indifferenziata (a costi minori e con un impatto nullo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini), ma anche perché avrebbe ricadute importanti dal punto di vista occupazionale, vista la manodopera richiesta su più turni a garanzia della non interruzione del processo di differenziazione.
Il fine lucrativo è tuttavia solo per pochi: l'inceneritore distrugge infatti preziosi materiali riutilizzabili, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, dove occorre evitare il più possibile gli sprechi. Una valida alternativa - che costerebbe un quinto rispetto all’inceneritore del Gerbido, per il quale si spendono invece 503 milioni di euro - è il Trattamento a Freddo Meccanico Biologico (TMB), con cui viene prodotta anche energia, senza però danneggiare l’ambiente e la salute con l’emissione di fumi altamente inquinanti. Tale procedimento consente di ricuperare il 70% circa di rifiuti in ingresso indifferenziati e/o avanzati dalla raccolta differenziata sfruttando l’abbinamento di metodi meccanici e di processi biologici, come la digestione anaerobica e il compostaggio. All’interno di questi impianti l’impiego di tecnologie all’avanguardia (come l’utilizzo di sistemi magnetici per separare i materiali contenenti metalli) non esclude anche il ricorso a metodi più tradizionali, ma non per questo meno efficaci, come la differenziazione “a mano” dei rifiuti. Il TMB è pertanto vantaggioso non solo perché consente il riutilizzo della porzione indifferenziata (a costi minori e con un impatto nullo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini), ma anche perché avrebbe ricadute importanti dal punto di vista occupazionale, vista la manodopera richiesta su più turni a garanzia della non interruzione del processo di differenziazione.
Un altro innegabile vantaggio, questo, rispetto ad un inceneritore, dove il personale è quasi esclusivamente composto da tecnici altamente specializzati (non necessariamente provenienti dall’area geografica dove sorge l’impianto). È chiaro che, nonostante tutti gli accorgimenti adottati, una piccola quantità di rifiuti trattati a freddo finisce comunque in discarica: tuttavia tale frazione (composta da inerti e pellicole di plastica) diminuirà progressivamente (dato che è composta da materiali teoricamente recuperabili, ma ancora di difficile riuso). Inoltre - come spiegato in precedenza - anche gli inceneritori hanno bisogno di discariche dove stoccare i residui della combustione (per di più tossici, mentre la potenzialità inquinante degli scarti del TMB è ridotta del 90%). Le emissioni di C02 (Anidride Carbonica) evitate grazie al TMB non hanno infine confronti rispetto non solo agli inceneritori, ma anche alle altre modalità di trattamento dei rifiuti. In Europa e in Italia il TMB è già una realtà. E a riprova che questo tipo di trattamento - a differenza di quanto sostiene TRM - si adatta bene anche ad un’estesa area urbana, citiamo i seguenti esempi di impianti TMB: Madrid - con un carico rifiuti trattati di 480.000 t/a (tonnellate all'anno) contro le 421.000 t/a di rifiuti bruciati dall'inceneritore del Gerbido -, Barcellona Ecoparc I - 300.000 t/a - e Barcellona Ecoparc II (265.000 t/a). A questo punto sorge spontanea una domanda, con cui concludiamo: perché non è possibile costruire impianti di trattamento a freddo anche a Torino?http://www.lospiffero.com/ballatoio/inceneritore-ecco-le-verita-nascoste-293.html
No comments:
Post a Comment